
Mostra: Biennale di Architettura di Venezia 2025
Curatore: Carlo Ratti
Argomento: Intelligenza. Naturale. Artificiale. Collettiva.
Luoghi espositivi: Giardini (26 padiglioni), Arsenale (22), centro storico di Venezia (15) - totale 65 nazioni, tra cui per la prima volta l'Azerbaijan, l'Oman, il Qatar e il Togo (parametric-architecture.com).
1. Bulgaria - "Pseudonatura"
Il padiglione si basa su un concetto semplice ma di grande impatto: una macchina per la neve che produce ghiaccio quando l'energia solare è al suo massimo. Questa macchina paradossale mostra come la tecnologia possa creare un'ecologia inversa: il freddo prodotto dal calore. Inoltre, il concept architettonico si ispira alla tradizionale stanza bulgara "odaya", uno spazio sociale per l'incontro, la conversazione e la riflessione. Qui, la natura diventa un laboratorio e la tecnologia un mediatore tra cambiamento e controllo.
2. USA – "PORCH: Un'architettura di generosità"
Il team americano ha trasformato il tradizionale "porch" – un portico, spazio tra pubblico e privato – in un luogo di incontro, dialogo e interazione tra culture. Il padiglione utilizza terra battuta e legno come materiali locali veneti, creando un'atmosfera di calore e inclusione. All'interno del padiglione sono collocati 54 moduli di autori diversi, che rappresentano diverse interpretazioni dell'architettura dell'ospitalità. Questo ha reso il padiglione un mosaico della società americana, un ritratto collettivo in cui tecnologia e memoria rurale coesistono.
3. Argentina – “Siestario”
Siestario evoca lo spazio immaginario della siesta – un momento di pausa tra le attività, un momento di riposo introspettivo. La sua struttura, ispirata ai silos, invita i visitatori a entrare, sdraiarsi e riposare. All'interno, sono esposte grandi fotografie in bianco e nero, senza una narrazione chiara, senza tempo, a sottolineare ulteriormente l'idea di fuga da un mondo frenetico. Questo progetto enfatizza la passività come resistenza: in un mondo di iperproduzione, la siesta diventa un atto di resistenza.
4. Emirati Arabi Uniti – “Pentola a pressione”
Ispirato alle pratiche agrotecniche locali, questo padiglione simula il microclima di una serra desertica. L'attenzione è rivolta alla resilienza e all'autosufficienza attraverso una gestione precisa delle risorse in climi estremi. L'architetto Azza Aboualam utilizza il concetto di "pressione" – sia fisicamente che simbolicamente – per interrogarsi sui limiti della vita in condizioni difficili. Il padiglione pone la domanda: può l'architettura diventare uno strumento di adattamento piuttosto che di dominio sulla natura?
5. Paesi nordici – “Potenza industriale”
Il Padiglione Nordico (Norvegia, Svezia, Finlandia) utilizza l'originale Padiglione Sverre Fehn come palcoscenico per performance e film. Cinque diverse installazioni esplorano i temi del lavoro, della resilienza, della corporeità e della memoria collettiva. L'architettura qui non è solo un edificio, ma anche un atto: una performance che osserva come il corpo crea e distrugge lo spazio. In questo modo, il padiglione esplora i confini tra industria, emozione e forma.
6. Belgio – “Costruire biosfere”
Il Padiglione Belga utilizza le piante non solo come decorazione, ma come elementi chiave dell'architettura. Le installazioni includono biosfere attive, sistemi di riciclo e moduli autosufficienti che fungono da spazi educativi. Il progetto sollecita la collaborazione tra agenti umani e non umani, ponendo l'ecologia al centro del pensiero architettonico. Dimostra il potenziale dell'architettura ibrida, in cui gli elementi verdi non sono un'aggiunta, ma una base.
7. Islanda – “Lavaforming”
L'Islanda usa la sua geografia unica – il suo paesaggio vulcanico – come ispirazione per un'edilizia sostenibile. Lavaforming esplora come potrebbe apparire l'architettura se fosse letteralmente plasmata dalle forze della natura. Attraverso modelli, simulazioni e materiali, il progetto suggerisce una città del futuro costruita in lava: durevole, resiliente e in simbiosi con il suo ambiente. Questo crea una nuova estetica che unisce spontaneità e raffinatezza.
8. Giappone – “IN-BETWEEN”
Il padiglione giapponese esplora il concetto di "ma" – lo spazio tra. Utilizzando l'intelligenza artificiale, gli autori reinterpretano i motivi architettonici tradizionali giapponesi e li traducono attraverso sistemi generativi. L'intelligenza artificiale diventa uno strumento, ma non l'autore: il padiglione usa la tecnologia per far rivivere i modelli culturali, non per sostituirli. I visitatori attraversano una serie di interspazi che creano un equilibrio sensoriale tra uomo, natura e algoritmo.
9. Brasile – "(Re)Invenzione"
Il Brasile concentra la sua attenzione sulle comunità indigene e sui loro saperi. L'architettura è presentata come un atto politico di resistenza alle strutture coloniali, attraverso l'uso di materiali naturali, tecniche locali e creazione collettiva. Le installazioni sono multisensoriali e includono elementi di performance, terra, suono e movimento. Il padiglione incoraggia la "reinvenzione" non solo dello spazio, ma anche dell'identità.
10. Danimarca – "Costruzione del sito"
Il team danese costruisce il padiglione direttamente sul sito, utilizzando materiali reperiti nell'ambiente: cemento riciclato, legno e pietra. Questo combina l'architettura con i principi ecologici dell'economia circolare. I visitatori possono assistere al processo di costruzione e decostruzione: il padiglione è temporaneo, ma trasmette un messaggio forte: la sostenibilità si fonda sul locale e sull'accessibilità.
11. Lettonia – "Paesaggio di difesa"
Il padiglione solleva interrogativi sui confini, sulle strutture difensive e sulle narrazioni spaziali della guerra. Attraverso l'uso di ostacoli fisici – come le barriere anticarro – e di installazioni che imitano il paesaggio militare, il padiglione esplora la geometria emotiva e visiva della difesa. È un'architettura del disagio, ma anche una testimonianza di resilienza e memoria.
12. Lussemburgo – "Investigazioni sonore"
Ispirato alla musica sperimentale e all'opera di John Cage, il padiglione utilizza il suono come materiale architettonico. Registrazioni di aree urbane e rurali del Lussemburgo vengono mixate in paesaggi sonori riprodotti nello spazio. Il visitatore si muove non solo attraverso lo spazio fisico, ma anche attraverso il paesaggio acustico, combinando così i sensi in una nuova forma di percezione.
13. Turchia – “A terra”
Il padiglione turco esplora il suolo, come mezzo fisico, ma anche come metafora della profondità culturale e del trauma. Attraverso l'installazione stratificata, include metodi tradizionali come la fabbricazione di mattoni in terra, ma anche rappresentazioni scientifiche moderne degli strati minerali. L'installazione evoca la profondità della memoria, l'archeologia e la comprensione climatica.
14. Germania – “Stress test”
La Germania usa la dicotomia "stress/de-stress" per illustrare la differenza tra esposizione e resilienza. Una parte del padiglione è chiusa, claustrofobica, intensa; l'altra è aperta, ariosa e riflessiva. Questa drammaturgia spaziale incoraggia il visitatore a un'introspezione sulla propria esperienza mentale e fisica dell'architettura.
15. Austria – "Agenzia per una vita migliore"
Il padiglione austriaco è concepito come una serie di ambienti funzionali – cucina, piscina, sala lettura – attraverso i quali si esplora la differenza tra le politiche abitative statali e le iniziative di base. Questo "appartamento per il pubblico" apre un dialogo sulla qualità della vita, la partecipazione e l'uguaglianza. Ogni stanza invita il pubblico a fermarsi e riflettere.
Contesto e fonti aggiuntive
- La Biennale è la più estesa fino ad oggi: più di 750 partecipanti e 300 progetti (carta da parati.com).
- Una svolta verso una ridefinizione critica dei padiglioni nazionali: il progetto Regno Unito-Kenya “Geology of Britannic Repair” interroga la storia coloniale (carta da parati.com).
- All'interno dell'Arsenal, dominano i progetti sperimentali di robotica e intelligenza artificiale, criticati per essere troppo focalizzati su aspetti accademici (theguardian.com).
Perché vale la pena sottolinearlo?
- I padiglioni interpretano le sfide globali: crisi climatica, tecnologia, migrazioni, ecologia e suono.
- Materiali: dalla lava, al terreno, al legno, al biocemento, alle installazioni di intelligenza artificiale.
- Collegamento ai valori locali e alle narrazioni globali: uno sfondo ideale per foto di storie "prima/dopo", dettagli del padiglione o interazioni con i visitatori.
Conclusione
Insieme, questi padiglioni formano un potente catalogo di pratica architettonica contemporanea: flessibile e profondamente impegnata, in risposta alle turbolenze climatiche, politiche, culturali e tecnologiche. Il post è pronto per la pubblicazione, con fotografie di alta qualità per aiutarvi a presentare ogni progetto: potete utilizzare la galleria fotografica all'inizio e poi le singole scene di ogni padiglione.
Se vuoi, posso suggerirti dove disporre meglio le immagini e come enfatizzare ulteriormente la narrazione nel post.





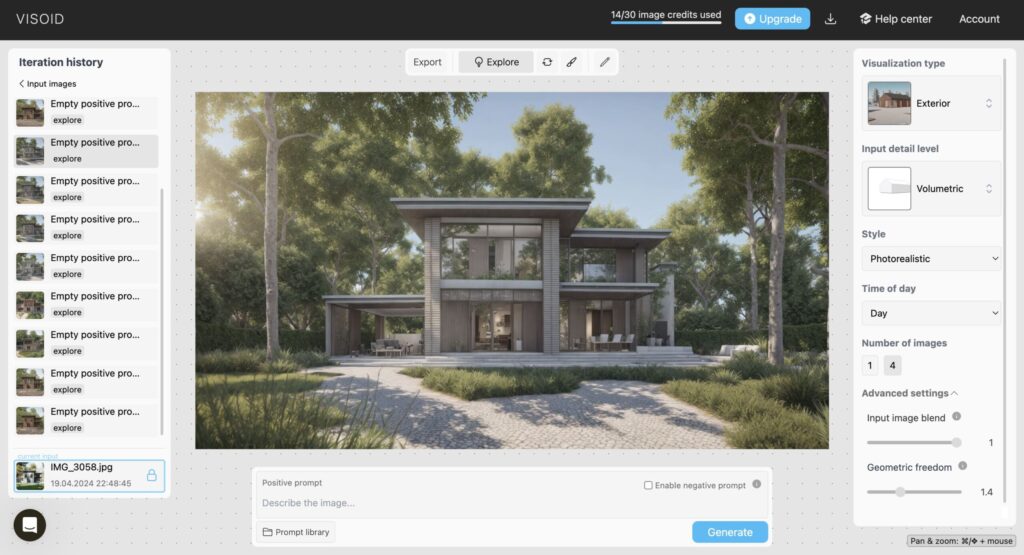
Risposte